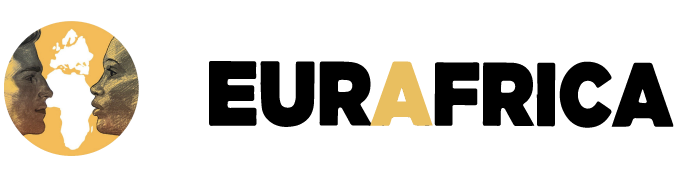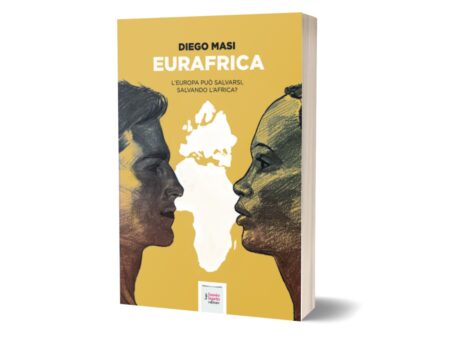Partiamo da un concetto estraneo alla nostra cultura cosiddetta occidentale: quello delle tribù, o meglio, delle micro-nazioni, come vengono definite dal premio Nobel Wangari Maathai nel suo libro The challenge of Africa.
Il fenomeno delle tribù non si è sviluppato in tutti i 54 paesi del continente, perché alcuni di essi hanno una storia e una tradizione di Stato, come Egitto, Etiopia, Mali, (paese che ha vissuto una delle più lunghe storie imperiali del XV secolo) o come i Paesi del Nord Africa (a esclusione della Libia).
Ma nelle altre nazioni, quelle che hanno subito maggiormente il fenomeno della colonizzazione e dell’imperialismo europeo e che hanno visto i propri confini ridisegnati a tavolino, la realtà delle micro-nazioni è ancora presente e continua a influenzare l’ecosistema sociale e politico.
Le micro-nazioni sono composte da persone della stessa etnia, spesso geograficamente vicine, che sovente parlano la stessa lingua, dislocate però in nazioni diverse:
“Esiste un forte sradicamento culturale in Africa che ha lasciato milioni di africani senza una propria identità, una scarsa fiducia in se stessi che possa dare adito a una capacità di prendere in carico le loro vite” scrive Wangari Maathai, non solo premio Nobel e scrittrice, ma parlamentare del Kenya fino alla sua morte.
Nella competizione politica attuale non vincono gli obiettivi e i programmi e i candidati non si differenziano per un’idea diversa di nazione, di valori e di riforme da portare avanti, ma per la tribù cui appartengono. Le pressioni al voto sono volte a far emergere il gruppo etnico che, in caso di vittoria, verrà favorito nelle opportunità economiche post elezioni.
Non esistono piattaforme sociali su cui le parti si scontrano. Non esiste l’alternanza tra mercato e uguaglianza, tra ricchi e poveri con le loro istanze, non esistono i sindacati che difendono i lavoratori. Esistono le tribù che riassumono tutto: in ogni tribù ci sono ricchi e poveri, lavoratori e disoccupati, sindacalisti e datori di lavoro.
Esemplificando in modo radicale, se vince una tribù, vince il capo e i suoi pochi amici che si spartiscono la torta, mentre tutti gli altri, anche quelli appartenenti alla medesima tribù, rimangono al palo. Si può capire, a questo punto, perché questi paesi non si sviluppino: la battaglia sociale è la madre di ogni progresso politico e senza di essa, è tutta aria fritta.
Gli Stati-nazione, anche quelli la cui democrazia appare più solida, sono visti da molti come istituzioni che “servono per dare passaporti, carte di identità”, scriveva Wangari Maathai “non certo la rappresentanza delle diversità razziali né le aspettative di queste tribù o micro-nazioni”.
Diciamolo in un altro modo e arriviamo a un dato politico rilevante: la battaglia elettorale avviene tra gruppi disomogenei, composti di ricchi e poveri, ma uniti dall’omogeneità culturale della tribù, che cercano di vincere in uno Stato di cui non riconoscono il potere e l’autorità.
Il loro unico scopo è suddividersi il potere economico.
Le piattaforme sono identiche, le promesse elettorali si alternano tra gli aumenti dei salari rivolti ai dipendenti statali e gli investimenti da stanziare per le infrastrutture. Le battaglie sono solo sulla corruzione e si riducono ad attacchi reciproci tra chi è più e chi è meno corrotto.
Il diritto all’uguaglianza non è praticato: nelle stesse micro-nazioni ci sono discrepanze e forti disuguaglianze, si combatte per il potere e chi lo ottiene divide i soldi, ma con l’unico risultato che il grosso della torta finisce nelle mani dei potenti, delle oligarchie e delle loro famiglie e neanche le briciole vengono redistribuite tra i componenti della tribù vincente.
Fino a quando lo Stato non sarà visto come una patria per cui lottare e la battaglia politica come una battaglia sociale, difficilmente la politica potrà rappresentare un motore di sviluppo. Nessun politico avanzerà mai piattaforme sociali con proposte innovative di battaglia sociale, di riqualificazione degli slum, di riforme agrarie, di sanità o di preoccupazione della mancanza di pensioni. Nessuno pensa al futuro, nessuno avanza idee per migliorare il welfare o creare opportunità di lavoro, se non a parole. Nessun candidato pensa mai ai diritti, a partire da quelli più elementari come quelli delle donne, sfruttate e sottomesse.
La politica purtroppo, fino a oggi, in molti paesi africani non riesce a incidere su programmi sociali di rilancio del paese, presa come è a difendere l’oligarchia di pochi contrabbandata come il potere della tribù. O è dittatoriale o golpista. Oppure come in molti paesi, più o meno la metà del continente, dichiarati democratici, la politica, anche se è formalmente moderata e occidentale nei toni, nel sistema elettivo e nei modi, è, appunto, come una partita di calcio con i suoi fan e i tifosi, più che uno strumento di creazione di consenso per una piattaforma riformista. Vince una squadra, prende il piatto, ma perde il Paese.
Se ti interessano questi temi continua a leggere i nostri articoli ed iscriviti alla newsletter